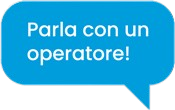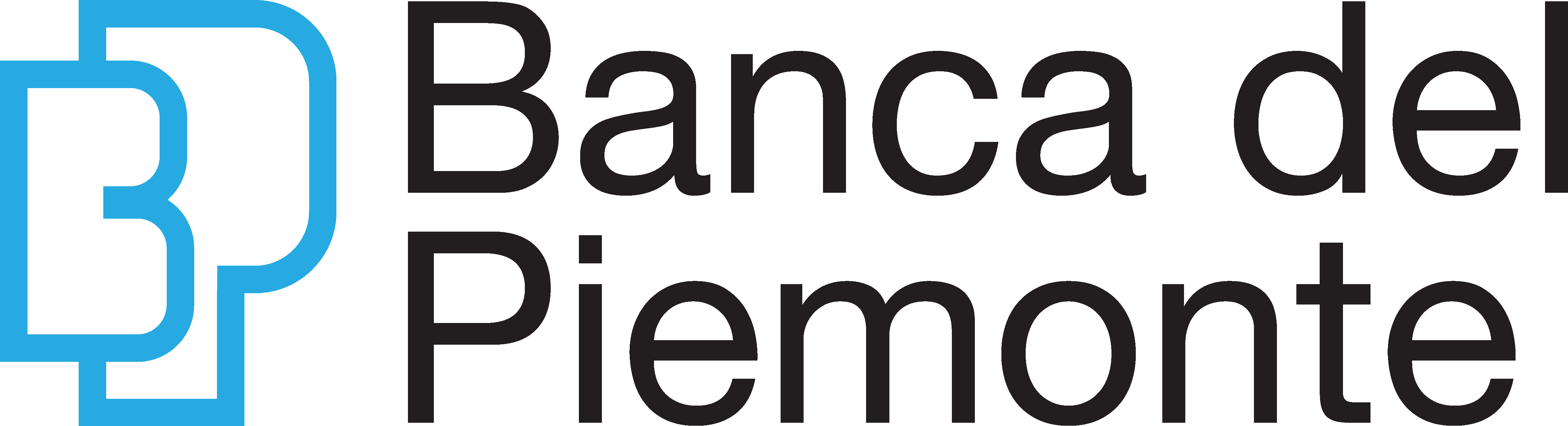da g.zucchetti | 16 Gen, 2023 | Imprese, News, Privati
Il 2022 è stato un altro anno negativo per il mercato automobilistico italiano; ma non per costruttori e concessionari dei modelli più lussuosi e costosi. Il fenomeno emerge chiaramente dall’analisi dei dati relativi ai sei segmenti ai quali convenzionalmente vengono attribuiti i diversi modelli offerti dalle Case nel nostro Paese.
Infatti, l’anno scorso, quando sono state vendute in Italia complessivamente 1.335.487 vetture, il 9,5% in meno rispetto al 2021 (1.475.411), gli unici due segmenti che hanno fatto registrare un incremento sono stati l’E (auto superiori) e F (alto di gamma), quelli dominati da Audi, Bmw, Mercedes, Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini e Tesla.
Le nuove immatricolazioni del segmento E sono state 28.955 (+4,4%) e quelle del segmento F 5.378 (+7,7). Tutti gli altri segmenti si sono contratti, a partire dall’A, quello delle auto più piccole (Fiat Panda e 500, Toyota Aygo, Hyundai I10, Kia Picanto e, fra le altre Suzuki Ignis) che ha perso addirittura il 22,3%, avendo evidenziato 202.550 vendite a fronte delle 260.732 del 2021.
È calato invece del 5,5% il segmento B (utilitarie) che comprende modelli quali Lancia Ypsilon, Dacia Sandero, Citroen C3, Ford Puma, Toryota Yaris, Peugeot 208, Renault Captur, Volkswagen T-Cros e Opel Corsa. L’anno scorso questa categoria ha avuto 524.619 acquirenti contro i 555.020 dell’anno precedente.
Ancora di più si è ridotto il segmento C, definito anche delle medie, come Jeep Renegade e Compass, Dacia Duster, Volkswagen T-Roc e Golf, Fiat 500X e Tipo, Peugeot 3008, Kia Sportage e Nissan Qashqai. Le immatricolazioni di questo segmento sono state 396.216, il 9,7% meno delle 438.701 del 2021.
Un po’ meno peggio del C è andato il segmento D, diminuito del 5,6%. Questa fascia di mercato, composta prevalentemente da Ford Kuga, Audi Q3, Q5 e A4, Volkswagen Tiguan, Mercedes Gla, Bmw X1 e X3, Alfa Romeo Stelvio, Toyota Rav4, ha fatto registrare 177.769 a fronte delle 188.242 del 2021.
Così, mentre sono calate le quote di mercato del segmento A (dal 17,7 al 15,2%) ed è rimasta invariata quella del C al 29,7%, sono cresciute quelle delle due fasce più alte, l’E dall’1,9 al 2,2% e l’F dallo 0,3 allo 0,4%.
In particolare, i modelli di maggior successo nell’alto di gamma sono stati le Porsche 911 (1.346 acquirenti l’anno scorso, ancora oltre cento più che nel 2021) e Taycan (641 a fronte dei 617 precedenti), la Mercedes Classe S (360), la Maserati Ghibli (352), la Porsche Panamera (350), la Merceds Gt coupe 4 (226), la Ferrari Roma (197), la Jaguar F-Type (183), la Lamborghini Urus (178) e l’Audi A8 (156).
La Ferrari nel 2022 ha contato in Italia 690 immatricolazioni (580 nel 2021), la Lamborghini 340 (299), l’Aston Martin 56 (46), la Porsche 7.419 (6.245), poche più dell’Mg che ne ha avute 7.373 (924), mentre sono calate quelle della Tesla a 5.600 dalle 6.045 del 2021.
Numeri, comunque, tutti di gran lunga inferiori a quelli della regina assoluta del mercato italiano, la Fiat Panda, della quale sono stati venduti altri 105.384 esemplari, ancora più del doppio del secondo modello preferito nel nostro Paese, cioè la Ypsilon della Lancia (40.970 immatricolazioni).

da g.zucchetti | 12 Gen, 2023 | Imprese, News, Privati
Nuovo record negativo per le nascite.
In Italia, nel 2021, ne sono state registrate 400.249, circa 4.500 in meno rispetto al 2020 (-1,1%). Lo ha comunicato l’Istat, aggiungendo che dal 2008 le nascite nel nostro Paese sono diminuite di 176.410 unità (-30,6%). E il nuovo calo è attribuibile, per la quasi totalità, alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (314.371 nel 2021, quasi 166 mila in meno rispetto al 2008).
Si tratta di un fenomeno di rilievo, in parte dovuto agli effetti strutturali indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente fissata tra 15 e 49 anni.
In questa fascia di popolazione, le donne italiane sono sempre meno numerose: da un lato, le cosiddette baby-boomers (ovvero le donne nate tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta) sono quasi del tutto uscite dalla fase riproduttiva; dall’altro, le generazioni più giovani sono sempre meno consistenti.
A partire dagli anni duemila l’apporto dell’immigrazione, con l’ingresso di popolazione giovane ha parzialmente contenuto gli effetti del baby-bust. Ma l’apporto positivo dell’immigrazione sta lentamente perdendo efficacia man mano che invecchia anche il profilo per età della popolazione straniera residente.
Nel complesso, a diminuire sono soprattutto le nascite all’interno del matrimonio, pari a 240.428, quasi 20 mila in meno rispetto al 2020 e 223 mila in meno nel confronto con il 2008 (-48,2%). Ciò è dovuto innanzitutto al forte calo dei matrimoni, che si è protratto fino al 2014 per poi proseguire con un andamento altalenante.
A ciò va aggiunto che nel 2020 la pandemia ha indotto molte persone a rinviare o a rinunciare alle nozze, al punto che il numero dei matrimoni si è pressoché dimezzato (-47,4%).
E la denatalità sembra destinata a proseguire nel 2022. Secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-settembre, le nascite sono diminuite di 6 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2021.
Nel 2021 i primi figli sono stati 186.485, il 46,6% del totale dei nati. La fase di calo della natalità avviatasi nel 2008 ha portato a una progressiva contrazione dei primogeniti che sono il 2,9% in meno sul 2020 (-5.657) e il 34,5% in meno sul 2008. La forte contrazione dei primi figli interessa tutte le aree del Paese, a eccezione della provincia di Bolzano.
Tale fenomeno testimonia la difficoltà che hanno le coppie, soprattutto le più giovani, nel formare una nuova famiglia con figli; problematica diversa rispetto all’inizio del millennio, quando la criticità riguardava soprattutto il passaggio dal primo al secondo figlio.
Tra le cause del calo dei primi figli vi è la prolungata permanenza dei giovani nella famiglia di origine, a sua volta dovuta a molteplici fattori: il protrarsi dei tempi della formazione, le difficoltà che incontrano i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro e la diffusa instabilità del lavoro stesso, le difficoltà di accesso al mercato delle abitazioni, una tendenza di lungo periodo di bassa crescita economica, oltre ad altri possibili fattori di natura culturale.
In un contesto di nascite decrescenti prosegue e si rafforza l’aumento dei nati fuori dal matrimonio: sono 159.821 nel 2021 (+14 mila nell’ultimo anno e +47 mila dal 2008), pari al 39,9% del totale (35,8% nel 2020). Nel caso di genitori entrambi italiani, i nati fuori del matrimonio raggiungono il 43%. Per i nati da genitori entrambi stranieri, la quota raggiunge il 26,5%, oltre 16 punti percentuali in meno rispetto alle coppie di entrambi italiani.
L’aumento della quota dei nati fuori dal matrimonio nell’ultimo anno, superiore alla media degli ultimi dieci anni, può essere messo in relazione al dimezzarsi dei matrimoni tra il 2019 e il 2020.
Fra l’altro, l’Istat ha rilevato che dal 2012 al 2021 diminuiscono anche i nati con almeno un genitore straniero (21.461 in meno) che, con 85.878 unità, costituiscono il 21,5% del totale dei nati.
Le boomers straniere, che hanno fatto il loro ingresso regolarmente come immigrate o sono “emerse” o sono stare “ricongiunte” a seguito delle regolarizzazioni di inizio secolo, hanno realizzato nei dieci anni successivi buona parte dei loro progetti riproduttivi nel nostro Paese, contribuendo in modo importante all’aumento delle nascite e della fecondità di periodo. Ma le cittadine straniere residenti, che finora hanno parzialmente riempito i “vuoti” di popolazione femminile ravvisabili nella struttura per età delle donne italiane, stanno a loro volta invecchiando.

da g.zucchetti | 9 Gen, 2023 | Imprese, News, Privati
Nei mesi invernali, in Italia, si contano 39 milioni di presenze turistiche, il 10,1% del totale annuale, prevalentemente nelle regioni più sciistiche: Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto.
Comunque, il turismo rappresenta un pilastro chiave dell’economia della montagna, “cluster per cui l’Italia è leader in Europa” si legge in uno studio di Confartigianato, dove si riporta che “secondo la classificazione di Eurostat, l’Italia è il primo Paese dell’Unione europea a 27 per Pil realizzato in province montane, territori in cui almeno metà della superficie e/o della popolazione è in aree montane: nel 2019 è ammontato a 805,6 miliardi di euro, il 44,9% del totale nazionale, una quota più che doppia rispetto al 20,7% registrato dalla media delle aree montane nell’Ue”.
Il valore dell’economia italiana della montagna, infatti, supera anche i 776,3 miliardi di euro della Spagna (62,4% del Pil), i 417,5 miliardi della Francia (17,1%) e i 241,5 miliardi della Germania (7%).
Nell’economia italiana della montagna, a fronte del 47,8% della popolazione nazionale, si concentra nel 2021 il 51,1% delle presenze turistiche totali e il 50,7% delle presenze turistiche straniere.
Confartigianato precisa che in Italia sono 63 le province montane e contano 2.077.826 micro e piccole imprese (mpi), attive con 5.137.434 addetti, i quali sono il 47,3% degli addetti nazionali delle mpi. Nel perimetro delle province che rappresenta l’economia italiana della montagna, le mpi rappresentano il 69,4% degli addetti delle imprese totali di tali province, una quota ampiamente superiore al 63,4% della media nazionale.
In particolare, nelle province montane sono 536.282 le imprese artigiane attive con 1.349.075 addetti, pari a oltre la metà (53%) degli addetti dell’artigianato italiano e al 18,2% degli addetti nazionali, quota superiore al 14,8% della media nazionale.
Nel 2021 l’economia della montagna rappresenta il 44,9% del valore aggiunto nazionale e in chiave settoriale presenta una quota più elevata per il valore aggiunto delle costruzioni (48,8%) e del manifatturiero esteso (48,6%), settori in cui è più alta la vocazione artigiana.
L’alta diffusione dell’artigianato e delle micro e piccole imprese rappresenta un fattore di coesione economica e sociale nelle aree di montagna, come approfondito in una precedente analisi della struttura imprenditoriale realizzata in collaborazione con gli Osservatori Mpi di Confartigianato Lombardia e di Confartigianato Emilia-Romagna.
Grazie alla diffusa presenza di imprese manifatturiere, l’economia della montagna realizza il 47,2% delle esportazioni nazionali, pari a 232,6 miliardi di euro.
Nei territori dell’economia della montagna si registra una maggiore propensione all’imprenditorialità e una più elevata presenza di lavoro autonomo: nelle province montane, a fronte del 47,3% di occupati totali nel 2021, si concentra il 49,8% degli occupati indipendenti – imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi – che rappresentano il 23% degli occupati di tali province, quota superiore di 2,2 punti al 20,8% delle altre province non montane.
Confartigianato riferisce, infine, che i dati sulle previsioni della domanda di lavoro delle imprese rilevati da Unioncamere-Anpal indicano che nel trimestre novembre 2022-gennaio 2023 nelle province montane sono previste 553mila entrate di lavoratori, pari al 46% di quelle nazionali.

da g.zucchetti | 2 Gen, 2023 | Imprese, News, Privati
Camillo Venesio, il nostro Amministratore Delegato, parla del futuro dell’economia sulle pagine de la Repubblica Torino.
Guerra, crisi energetica, inflazione: il 2023 parte con le stesse criticità dell’anno passato eppure rassicura “non c’è motivo di essere troppo angosciati“.
Tra le altre cose, parla anche della nostra città: “E’ indubbio che Torino stia faticando, ma il futuro è davvero nelle nostre mani: ci sono tutte le risorse intellettuali, umane e finanziarie per riprenderci”.
Leggi l’intervista completa

da g.zucchetti | 1 Gen, 2023 | Imprese, News, Privati
I dati dei primi sei mesi del 2022 hanno segnato per i maggiori player mondiali della moda un incremento del giro d’affari del 15%. In particolare, il mercato europeo ha spinto di più (+24%) insieme con quello americano (+19%, trainato dagli Stati Uniti), mentre l’Asia è stata penalizzata dalle restrizioni legate al Covid-19 (+3%). E nonostante l’attuale scenario macroeconomico, per l’intero 2022 le aspettative del settore restano positive: i primi dati indicano una crescita media del fatturato del 18% nei primi nove mesi.
Lo si legge nel nuovo report dell’Area Studi Mediobanca sul Sistema Moda Mondo che analizza i dati finanziari delle 78 maggiori multinazionali della moda con ricavi superiori a un miliardo di euro ciascuna, di cui 35 hanno sede in Europa, 29 in Nord America, 12 in Asia e due in Africa.
Le multinazionali della moda sono supportate da fondamentali solidi e stanno incrementando i propri listini (+6% in media previsto nel 2022) in risposta ai rialzi dei costi produttivi nonché alle pressioni valutarie. Innovazione e sostenibilità si confermano le principali leve per lo sviluppo del settore e il mercato asiatico resta di primaria importanza, con un’attenzione particolare alle generazioni più giovani e ai consumatori cinesi.
Nel 2021, le 78 maggiori multinazionali della moda hanno fatturato complessivamente 497 miliardi di euro (+26% sul 2020, superando dell’8,5% i livelli pre-pandemici), di cui il 57% generato dai player europei e il 33% dai nordamericani.
Fra i 35 gruppi europei, l’Italia con le sue nove big è il Paese più rappresentato a livello numerico, ma è la Francia, con una quota del 40% del fatturato aggregato, ad aggiudicarsi il primato per giro d’affari davanti a Germania (12%) e Regno Unito (11%), con l’Italia al 6%.
Al primo posto per ricavi tra i colossi mondiali si conferma LVMH (64,2 miliardi). Seguono Nike (41,2), la spagnola Inditex (27,7) che controlla Zara, la tedesca Adidas (21,2), l’italo-francese EssilorLuxottica (19,8), la svedese H&M (19,4) e il gruppo svizzero Richemont (€19,1).
Prima tra gli italiani Prada (3,4 miliardi), al 33° posto nella classifica mondiale, seguita da Calzedonia Holding (46.a), Moncler (52.a) e Giorgio Armani (54.a).
L’incremento dei ricavi nel 2021, rispetto ai livelli pre-pandemici, vede primeggiare la britannica Farfetch (+90,5%) davanti alla statunitense Crocs (+87,9%). Farftech, fondata nel 2007, è anche la società più giovane, seguita dalle connazionali Boohoo (2006) e Asos (2000) e dalla stessa Crocs (1999).
Anche la redditività supera i livelli pre-crisi: ebit margin aggregato al 15,8% dal 9,1% del 2020 e il 13,1% del 2019. Hermès si conferma al primo posto (ebit margin al 40,1%), davanti a Chanel (35,3%) e LVMH (31,7%). Seguono Crocs (29,6%), Kering (28,4%) e Moncler (28,3%), prima italiana in classifica.
In rialzo, ma ancora al di sotto dei livelli del 2019, gli investimenti, cresciuti del 20,6% sul 2020 ma ancora inferiori del 5,9% rispetto al 2019. Solo i gruppi asiatici hanno investito con intensità superiore (+22,7% sul 2019), mentre i player europei li hanno ridotti del 6% e quelli nordamericani arretrano tre volte tanto (-22,6%).
La distribuzione di dividendi resta allineata ai livelli pre-crisi, con l’eccezione dei player europei che hanno remunerato gli azionisti in misura lievemente maggiore (+3,3%).
Sul fronte patrimoniale, le multinazionali della moda si distinguono per una struttura finanziaria più solida rispetto alla media della grande manifattura (debiti finanziari sul capitale netto al 68,3% vs 88%), con i gruppi europei più capitalizzati di quelli statunitensi (59,7% vs 106,9%). La svizzera Swatch e la danese Bestseller sono le più solide (0,9% per entrambe).
Il 39% della forza lavoro delle 78 multinazionali della moda ha mediamente meno di 30 anni; la maggiore concentrazione di occupati giovani è nelle statunitensi (55%), le europee si fermano al 37% e le italiane si collocano sotto la media continentale (32%). Il ricorso al part-time è più intenso nei gruppi statunitensi (50%) rispetto a quelli europei (22%), con le società italiane che registrano il valore più basso (8%) insieme alle francesi (9%). I player europei utilizzano più contratti a tempo indeterminato (85%) rispetto agli statunitensi (79%).
Dall’analisi della varietà di genere nei board emerge che la presenza femminile cala all’aumentare del livello di responsabilità in azienda: la quota di donne sul totale della forza lavoro è mediamente pari al 64%, ma scende al 44% nei ruoli direttivi e al 33% a livello di cda. I gruppi statunitensi hanno più consiglieri donna (38%) rispetto a quelli europei (33%). Ampiamente sopra la media europea si collocano i player francesi i cui cda sono composti per la metà da donne; i gruppi tedeschi si fermano al 29% e quelli italiani al 28%. Le meno rappresentate sono le donne giapponesi: solo una ogni dieci consiglieri.
Le 78 multinazionali della moda hanno occupato quasi 2,2 milioni di persone nel 2021, in ridimensionamento dell’1,4% sul 2019. Relativamente alla supply chain, i fornitori dei maggiori player mondiali della moda sono localizzati per il 62% in Asia, per il 29% in Europa e per il 7% nelle Americhe, con punte di oltre il 90% in Asia per il fast fashion e le calzature sportive. Il ricorso a fornitori asiatici è più marcato per i gruppi nordamericani rispetto a quelli europei (76% vs 44%) che concentrano nel Vecchio Continente oltre la metà dei propri fornitori (52%), seguendo una strategia di prossimità e maggiore qualità.
Infine, un segnale inequivocabile dell’eccellenza del Made in Italy: mediamente oltre un quarto dei fornitori dei gruppi europei della moda ha sede in Italia, con picchi di oltre l’80% nella fascia alta del mercato.
Relativamente alla rete distributiva, nel 2021 sono lievemente aumentati i punti vendita a livello globale (+0,7% sul 2020) trainati dall’area asiatica (+4,2%), mentre sono in ridimensionamento quelli in Europa (-1,9%) e Nord America (-1,6%).