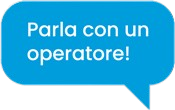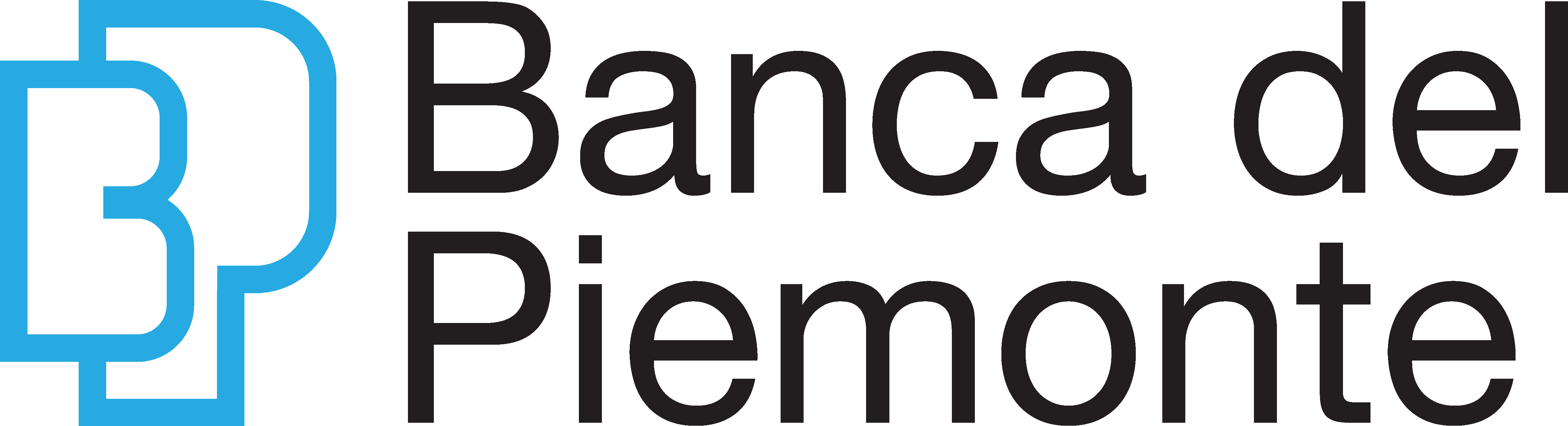da g.zucchetti | 8 Feb, 2023 | Imprese, News, Privati
Sono sempre di più gli italiani che si spostano su due ruote, a pedale o motorizzate e aumenta ancora, anche se in modo modesto, la disponibilità di piste ciclabili, dopo l’impennata del 2020. Inoltre, torna a salire la sharing mobility e il suo utilizzo, con una marcata prevalenza dei monopattini.
È quanto emerge dal settimo rapporto dell’Osservatorio Focus2R, la ricerca promossa da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente.
L’indagine fornisce la più completa e aggiornata panoramica delle politiche introdotte dai Comuni capoluogo di provincia italiani dedicate a ciclisti urbani e motociclisti.
Malgrado si confermi ancora profondo il divario tra Nord e Sud nelle misure introdotte, l’ultima rilevazione descrive comunque, tra luci e ombre, una progressiva ascesa dell’attenzione alla mobilità su due ruote nell’agenda politica delle città italiane.
Un incremento che, però, si dimostra ancora non proporzionale all’andamento del mercato di biciclette e motocicli e alla loro presenza in ambito urbano (oltre 1,9 milioni le biciclette vendute nel 2022, quando sono stati immatricolati 291 mila ciclomotori, scooter e moto).
BICICLETTE – Dal rapporto fra l’altro risulta che la disponibilità media di piste ciclabili raggiunge 9,86 metri equivalenti ogni 100 abitanti e, per quanto riguarda i servizi di bike sharing, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Padova contano, da sole, il 71% della flotta complessivamente disponibile in tutti i capoluoghi. Nel 2021 il numero complessivo di bici in sharing a stazione fissa è di 12.184 di cui 2.272 a pedalata assistita e 9.912 tradizionali, in aumento rispettivamente del 2,7% e del 7% rispetto al 2020.
Tra le città con il maggior uso di bike sharing troviamo Milano, Brescia, Firenze, Padova, Torino e Bologna, tutte attorno al milione di prelievi annui, tranne Milano che ne registra quattro milioni. Il numero di prelievi totali annui è aumenta del 7% rispetto al 2020.
MOTOCICLI – Con una media di 13,53 motocicli ogni 100 abitanti (erano 12,5 nel 2017), cresce nelle città italiane anche l’utilizzo di ciclomotori, moto e scooter. Ma rimane ancora limitato l’accesso dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici: una possibilità non permessa nell’89% delle città. Rispetto al 2020, inoltre, è diminuito è sceso da otto a tre il numero dei capoluoghi in cui l’accesso è consentito in tutte o nella maggior parte delle corsie (Taranto, Imperia e Venezia); mentre l’ingresso è permesso solo in alcune corsie a Bergamo, Como, Genova, Milano e Reggio Calabria.
Poco confortanti anche i dati che riguardano la sicurezza. Rimane infatti pressoché invariato il numero dei comuni che scelgono di puntare sull’estensione di strade dotate di guardrail con specifiche protezioni a tutela dell’incolumità dei motociclisti in caso di impatto e peggiora anche il dato sul miglioramento della sicurezza negli strumenti di pianificazione comunale, che non è percepito come una priorità per il 39% città interessate dallo studio.
Per quanto riguarda la mobilità condivisa, nel 2021 lo sharing di moto e scooter elettrici risulta disponibile in 14 comuni, sei in più rispetto al 2020 e 11 in più rispetto al 2015.
MONOPATTINI – In forte crescita la diffusione dei servizi di monopattino-sharing, che nel 2021 ha registrato la metà dei noleggi totali fatti in Italia (17,8 milioni) e raddoppiato il numero di noleggi del 2020. Dal rapporto emerge che il 52% dell’intera flotta di mobilità condivisa (car sharing, scooter sharing, bike sharing, monopattino sharing) è rappresentata dai monopattini.
Nel 2021 il 41% delle 98 città che hanno fornito una risposta dichiara di avere un servizio di sharing di monopattini elettrici. Roma registra il maggior numero di veicoli disponibili (14.500), seguita da Milano (5.250) e Reggio Emilia (1.600) veicoli disponibili. Bari con 1.500 veicoli e Pescara con 500 manifestano un alto utilizzo di tali mezzi rispetto alle altre città.
Per quanto riguarda, infine, gli incidenti con lesioni a persone che coinvolgono i monopattini elettrici sono stati denunciati 2.000 incidenti, con 2.107 feriti e 10 morti.
Il presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri, ha commentato: “è evidente che le due ruote sono sempre più una risposta alla nuova domanda di spostamenti che viene dalla città; per questo, chiediamo maggiore attenzione a tutti i livelli e guardiamo con preoccupazione ai tagli degli investimenti su infrastrutturazione ciclabile e sicurezza. Al contempo siamo anche convinti che la discussione sulla mobilità urbana non possa sicuramente tralasciare i motocicli, che rappresentano una soluzione di mobilità individuale fruibile, sostenibile e molto apprezzata dai cittadini”.

da g.zucchetti | 6 Feb, 2023 | Imprese, News, Privati
Il Piemonte è tra le regioni virtuose presentando 1,767 milioni di occupati a fronte di 1,736 milioni di pensioni erogate e, perciò, un saldo positivo di 32 mila.
In media nazionale, comunque, si calcolano 267 pensionati ogni 1.000 abitanti; tale valore è più alto per le donne come conseguenza della maggiore speranza di vita
Sono 22,759 milioni le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2021, erogate a 16 milioni di titolari, per una spesa di 313 miliardi di euro. Lo ha comunicato l’Inps, precisando che il 90,5% della spesa complessiva (283 miliardi) è destinata alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs). In particolare, il 72,6% del totale (227 miliardi) è rivolto al pagamento delle pensioni di vecchiaia e anzianità, il 13,9% alle pensioni ai superstiti (43 miliardi), il 4% a quelle di invalidità (13 miliardi).
Il sistema dei trasferimenti pensionistici impegna ulteriori 25 miliardi per la copertura di 4,4 milioni di prestazioni assistenziali (invalidità civile, accompagnamento, assegni sociali e pensioni di guerra) finanziate dalla fiscalità generale. Alle prestazioni di tipo Ivs e assistenziali si aggiungono 4,1 miliardi erogati a copertura di quasi 700mila rendite dirette e indirette per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Nel 2021 la spesa pensionistica è aumentata di 1,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente e ha rappresentato il 17,6% del Pil (era il 18,5% nel 2020 e il 16,7% nel 2019).
Anche il rapporto tra numero di pensionati e occupati risente dell’effetto della crisi sanitaria: è di 714 beneficiari ogni 1.000 lavoratori (717 nel 2020 e 694 nel 2019). Se si considerano solo i titolari di prestazioni previdenziali, il rapporto tra pensionati che hanno versato i contributi e i lavoratori che li versano scende a 624 ogni 1.000 lavoratori.
Anche se di sole 205 mila unità, a livello nazionale il numero delle pensioni erogate agli italiani ha superato la platea costituita dai lavoratori autonomi e dai dipendenti occupati nelle fabbriche, negli uffici e nei negozi (22,554 milioni addetti). La situazione più “squilibrata” si verifica nel Mezzogiorno e, al Nord, in Liguria, dove si contano 665 mila pensioni erogate a fronte di 595 mila occupati.
Il Piemonte è tra le regioni virtuose presentando 1,767 milioni di occupati a fronte di 1,736 milioni di pensioni erogate e, perciò, un saldo positivo di 32 mila. In particolare, ecco i saldi delle singole province: Torino +30 mila (869 mila pensioni e 899 mila occupati), Alessandria -10 mila (rispettivamente 88 mila pensioni e 172 mila occupati), Asti + mille (88 mila e 89 mila), Biella -14 mila (83 mila e 69 mila), Cuneo +29 mila (232 mila e 261 mila), Novara +9 mila (141 mila e 150 mila), Verbania -mille (64 mila e 63 mila), Vercelli -11 mila (76 mila e 65 mila),
In media nazionale, comunque, si calcolano 267 pensionati ogni 1.000 abitanti; tale valore è più alto per le donne come conseguenza della maggiore speranza di vita.
Complessivamente, il 59,1% delle singole prestazioni pensionistiche è di importo inferiore ai 1.000 euro lordi mensili. Però, considerando che il 32,1% dei pensionati riceve più di una prestazione, il reddito pensionistico complessivo – dato dalla somma degli importi delle singole prestazioni – è comunque inferiore a tale soglia per un terzo dei pensionati (32,8%).
Le donne sono la maggioranza sia tra i titolari di pensioni (55%) sia tra i beneficiari (52%), ma gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici. In media, l’importo di una pensione di una donna è più basso rispetto a quello riservato agli uomini per lo stesso tipo di pensione (11mila contro 17mila euro) e i redditi mediani percepiti dalle donne sono inferiori del 28% rispetto a quelli degli uomini (14.529 contro 20.106 euro).
La disuguaglianza di genere è influenzata principalmente dalla minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e spesso da carriere discontinue e quindi da storie contributive più brevi e frammentate, caratterizzate anche da un differenziale retributivo generalmente svantaggioso. Infatti, per una pensione di vecchiaia un uomo percepisce 20mila euro lordi annui e una donna solo 11mila. Ciascun beneficiario di pensione percepisce in media 1,4 prestazioni, anche di diverso tipo. Ma, nel complesso, più di due terzi dei pensionati (67,9%) beneficiano di una sola prestazione.
In media, per l’anno 2021, i pensionati da lavoro che percepiscono anche un reddito da lavoro sono 444 mila, il 13,3% in più rispetto al 2020. L’età media dei pensionati che lavorano è progressivamente cresciuta: il 78,6% ha almeno 65 anni e il 45,4% ne ha almeno 70.
L’Inps stima che in quasi una famiglia su due sia presente almeno un pensionato (oltre 11,8 milioni di nuclei). Per le famiglie con almeno un titolare di pensione, i trasferimenti sociali in favore dei pensionati rappresentano, in media, il 64% del reddito familiare netto disponibile; la quota restante è costituita per il 27,8% da redditi da lavoro e per l’8,3% da altri redditi (primariamente affitti e rendite finanziarie).
Per oltre 7,1 milioni di famiglie (il 60% delle famiglie con pensionati) i trasferimenti pensionistici costituiscono più dei tre quarti del reddito familiare disponibile; nel 24,4% dei casi le stesse prestazioni sono l’unica fonte di reddito (quasi 2,9 milioni di famiglie), mentre per il 25,6% delle famiglie il loro peso non supera la metà delle entrate familiari.

da g.zucchetti | 2 Feb, 2023 | Imprese, News, Privati
In quattro famiglie italiane su dieci (40%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a dura prova dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa anche a causa dell’esplosione dei costi dell’energia.
È quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti, secondo la quale tra le famiglie che hanno un nonno pensionato in casa, quasi i due terzi (63%) dichiarano che i nonni sono un fattore determinante non solo per contribuire al reddito familiare e il 22% anche perché li considera un valido aiuto magari per portare i bambini a scuola e seguirli una vola tornati a casa.
Fra l’altro, quest’ultima è una scelta che dà maggiore fiducia e consente di risparmiare su doposcuola e baby sitter.
Inoltre, il 15% delle famiglie con nonni conviventi – aggiunge Coldiretti – trova in loro un aiuto a livello lavorativo, soprattutto per chi è occupato nell’agricoltura piuttosto che nell’artigianato o nel commercio.
“Come nella migliore tradizione agricola – spiega la Coldiretti – la presenza degli anziani fra le mura di casa è quindi quasi sempre considerata un valore aggiunto all’interno di un welfare familiare che deve fare i conti sia con la gestione delle risorse economiche disponibili sia con quella del tempo e dei figli, in situazioni che vedono molto spesso entrambi i genitori occupati e fuori casa per la maggior parte della giornata”.
Non solo: la presenza dei nonni si rivela sempre più importante anche rispetto alla funzione fondamentale di conservare le tradizioni alimentari e di guidare i più giovani verso le abitudini salutari.
Lo stile nutrizionale basato sui prodotti della dieta mediterranea, come pane, pasta, frutta, verdura, carne, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari, ha consentito in Italia una speranza di vita tra le più alte a livello mondiale, pari a 79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne.
“Considerata per anni, a torto, come una forma arcaica da superare, la presenza degli anziani all’interno della famiglia si sta dimostrando fondamentale per affrontare le difficoltà economiche e sociali di molti cittadini” ha detto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando che “la solidarietà tra generazioni, sulla quale si fonda l’impresa familiare, è un modello vincente per vivere e stare bene insieme e non un segnale di arretratezza sociale e culturale, come è stato spesso affermato”.
Ancora a proposito degli anziani, la Coldiretti ha scritto che 1,3 milioni di loro hanno anche il merito di custodire le bellezze dei piccoli borghi italiani, combattendone lo spopolamento, tramandando le tradizioni e i saperi, difendendo il valore storico, ambientale e culturale locale.
Nei 5.529 comuni italiani con meno di 5mila abitanti (il 70% del totale), più di un residente su otto (13%) ha più di 75 anni. La popolazione senior, perciò, rappresenta una presenza fondamentale per garantirne la vivibilità di queste località, che ospitano il 16,5% della popolazione nazionale ma occupano il 54% della superficie del Paese.
Non è un caso, comunque, che il 92% delle produzioni tipiche italiane nasca nei piccoli borghi, costituendo un patrimonio dell’enogastronomia sostenibile e a km zero conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano.
Fra l’altro, in campagna, gli anziani non solo sono impegnati nel presidio delle aree rurali ma, spesso, sono anche il motore di iniziative ed esperienze culturali, economiche e turistiche, che valorizzano la gastronomia tradizionale, trasmettono alle nuove generazioni la capacità manuale di realizzare oggetti di artigianato o di fare l’orto; tramandano i proverbi della saggezza contadina e i rimedi della nonna all’insegna della naturalità e del risparmio.

da g.zucchetti | 31 Gen, 2023 | Imprese, News, Privati
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, nell’intento di dare un giusto riconoscimento a coloro che hanno contribuito con impegno costante alla crescita dell’economia locale, ha presentato il concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico.
Si tratta di una manifestazione tradizionale che premia i lavoratori dipendenti (in servizio o in pensione) che hanno dedicato almeno 35 anni di lavoro ad una stessa azienda e gli imprenditori che hanno gestito un’impresa da almeno 35 anni ovvero hanno ereditato e continuato un’attività imprenditoriale con più di 50 anni di vita.
Quest’anno sono stati premiati anche tre nostri colleghi: Danilo De Stefani, Stefania Franchini e Massimo Scarpulla.
Un evento ricco di emozione per tutti i partecipanti e anche per la nostra Banca.
Un grazie speciale ai nostri colleghi per la loro dedizione ed il loro impegno, che il vostro percorso possa essere un monito per tutti.




da g.zucchetti | 30 Gen, 2023 | Imprese, News, Privati
Alla fine del 2021, la ricchezza netta delle famiglie italiane, misurata come somma delle attività reali (abitazioni, terreni, altri immobili) e delle attività finanziarie (depositi bancari, titoli, azioni, ecc.), al netto delle passività finanziarie (prestiti a breve termine, a medio e lungo termine e altri debiti), è risultata pari a 10.422 miliardi di euro, ossia 176 mila euro pro capite.
La ricchezza netta è aumentata di oltre 300 miliardi a valori correnti rispetto all’anno precedente (+3%), proseguendo la crescita iniziata nel 2019 e non interrotta dalla crisi pandemica; ma in termini reali si è ridotta dell’1,1%, in controtendenza rispetto a quanto osservato nel 2020 (+1,7%). Le attività reali (6.186 miliardi di euro) sono aumentate dello 0,3% a prezzi correnti (+16 miliardi), soprattutto per effetto delle abitazioni (+23 miliardi), il cui valore ha registrato una crescita per la prima volta dal 2012. Il valore degli immobili non residenziali, invece, si è ridotto (-1,5%), proseguendo la fase di contrazione in atto dal 2012.
Le attività finanziarie (5.237 miliardi) hanno segnato una crescita più robusta rispetto a quelle reali, pari al 6,6% (per un controvalore di 325 miliardi), trainata prevalentemente dalle azioni (+150 miliardi) e dalle quote di fondi comuni (+89 miliardi). È stata rilevante anche la crescita dei depositi (+70 miliardi), seppure meno accentuata di quanto osservato nel 2020 (+104 miliardi).
Le passività finanziarie sono aumentate del 3,7%, superando la soglia dei 1.000 miliardi. Si è osservato, in particolare, un incremento della componente dei prestiti (+3,8%).
A differenza di quanto registrato l’anno prima, nel 2021 la crescita della ricchezza finanziaria delle famiglie è tornata a beneficiare ampiamente dei guadagni in conto capitale (+4,3%, per un aumento complessivo di 210 miliardi), legati soprattutto alle azioni e alle quote di fondi comuni.
Questi dati sono della Banca d’Italia, la quale ha aggiunto che la ricchezza netta delle imprese a fine 2021 è risultata pari a 880 miliardi, l’8% in meno rispetto al 2020. Infatti, a fronte di un incremento della ricchezza lorda di circa 150 miliardi, a cui ha fortemente contribuito l’aumento dei depositi (+49 miliardi), le passività sono cresciute di 225 miliardi, principalmente per effetto dell’aumento del valore delle azioni e altre partecipazioni.
Tra le attività reali delle imprese, dopo la contrazione del 2020, ha ripreso a crescere il valore degli impianti e macchinari (+4,1%) che, insieme a quello delle altre opere (+5,7%), ha più che controbilanciato il calo del valore degli immobili.
Nel caso delle società finanziarie, poi, tra il 2020 e il 2021 la ricchezza netta è scesa da 717 a 686 miliardi. L’aumento della ricchezza lorda (+416 miliardi), costituita quasi esclusivamente da attività finanziarie, è risultato infatti inferiore a quello delle passività (+447 miliardi), il cui aumento è stato guidato dalla raccolta di depositi (+9,9%).
Infine, le amministrazioni pubbliche: alla fine del 2021 presentano un indebitamento netto di 1.467 miliardi, anche se il totale delle loro attività, sia finanziarie sia reali, è cresciuto del 3,6%; in particolare per quelle reali, la crescita è stata guidata dall’aumento del valore delle opere del genio civile (+24 miliardi) e degli immobili non residenziali (+9 miliardi).
Tornando alle famiglie, Banca d’Italia ha rilevato che alla fine del 2021 oltre la metà della loro ricchezza lorda era composta da attività reali (54%) e, in particolare, da abitazioni (45%) e immobili non residenziali (6%). Quanto all’incidenza delle attività finanziarie è salita al 46% dal 44% del 2020. In particolare, nel portafoglio finanziario si è osservata una costante diminuzione della quota di titoli (dall’8 al 2%, tra il 2005 e il 2021) a favore di altri strumenti finanziari, in particolare quelli del risparmio gestito (dall’11 al 17% nello stesso arco temporale).
Lo stock di azioni e altre partecipazioni (nel 2021 pari all’11% del totale della ricchezza lorda) è aumentato di un punto percentuale rispetto al 2020, riavvicinandosi ai livelli del 2005 (12%).
Comunque, la ricchezza netta delle famiglie italiane cresce meno che negli altri Paesi: a fine è risultata pari a 8,6 volte il reddito disponibile, valore superiore a quelli di Germania, Regno Unito e Stati Uniti, ma inferiore a quanto registrato dalle famiglie canadesi, francesi e spagnole.
Misurata poi in rapporto alla popolazione, la ricchezza netta pro capite delle famiglie italiane alla fine del 2021 era inferiore a quella di tutti gli altri Paesi, a eccezione della Spagna.